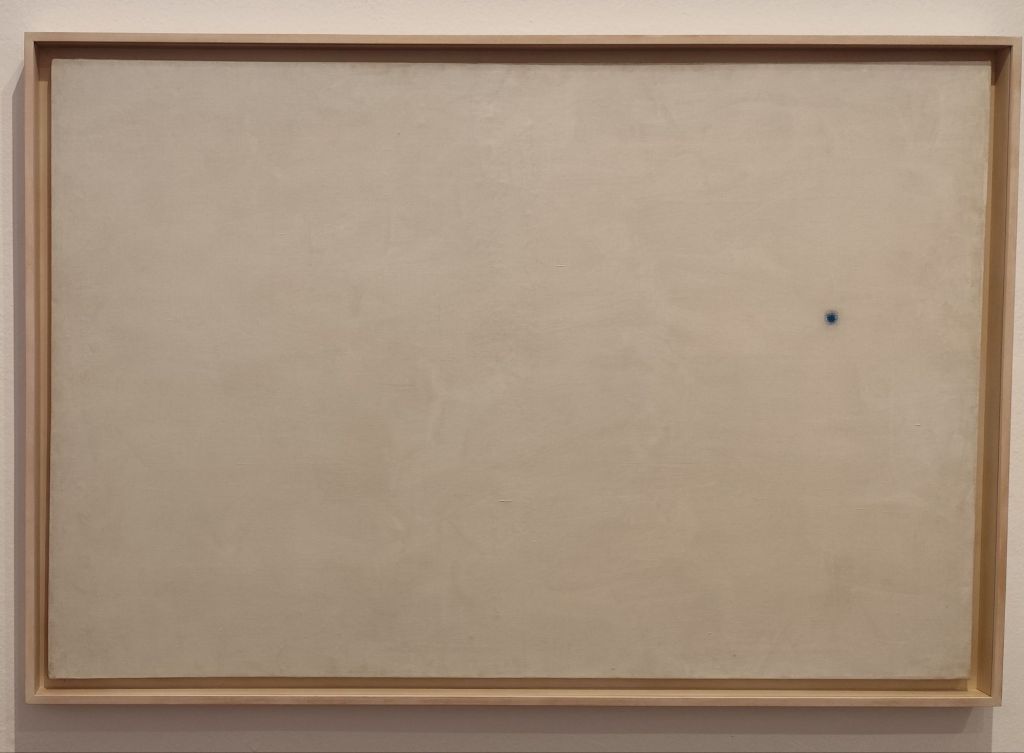I
Qualcuno doveva avermi calunniato, perché a inizio primavera, in un anno come tanti, senza particolari avvisaglie date dal fisico, dal clima, dal contesto socioeconomico e politico, si presentò alla porta la morte. Aspetto sui trent’anni, aria tendenzialmente annoiata, una giacca troppo grande, mi chiese di entrare e, aprendo una borsa voluminosa mi disse, sciorinando una serie di frasi evidentemente frutto di qualche corso di comunicazione efficace – a quanto pare le disgrazie di questo mondo si diffondono anche nell’aldilà: “Gentilissimo Pellegrino, possiamo darci del tu? Allora, so che questa notizia è un po’ imprevista per te, ma sei stato inserito nel decreto flussi del Ministero per il passaggio nel mondo di là. Capisco la sorpresa, ma ti inviterei a pensare a questo evento come a un’opportunità. Parliamoci chiaro: qui, stai facendo schifo. A trent’anni fai un lavoro che non ti piace, il sistema politico non è granché e, lasciami dire, i servizi e il welfare nel mondo di là sono molto meglio di quello che avete lì. Per dire, di là ogni estate il Ministero per il Benessere dei Defunti organizza vacanze alle terme della durata di due mesi. A volte la compagnia non è esaltante (a me una volta hanno messo in coppia per le attività con un cavaliere dei Tercios spagnoli che parlava solo di armi da guerra pesanti), però sicuramente molto meglio della tua settimana e mezzo ad agosto in cui vai a elemosinare un ombrellone a Tirrenia per poi tornare in ufficio più stanco di prima.”
Ci riflettei su, perché qualcosa non quadrava. “Signorina – devo chiamarLa dottoressa? Mi dica Lei – fece un cenno con la testa a dire che forse sì, era meglio dottoressa, alla luce delle sue due lauree in Morte e rare resurrezioni e al suo Master universitario di secondo livello in Decessi violenti da precipitazione: gestire la comunicazione per un transito felice – allora, forse sono male informato, ma gli opuscoli di cui sono in possesso sui benefit del mondo di là che Lei sponsorizza così amabilmente parlano di altro. Secondo quello che scrivono loro, di là se va male c’è il fuoco eterno, che, mi perdoni, vorrei anche ritardare se possibile, mentre se va bene si rimane in contemplazione di Dio, ma, insomma, senza grandi attività da svolgere, anche considerando che è una cosa da fare per l’eternità.”
“Tutte calunnie, il Ministero della Morte non ha mai commissionato opuscoli ufficiali sulle offerte del mondo di là e ha sempre invitato a diffidare di chi dice di esserne il portavoce, che sia al telefono o che sia attraverso opuscoli pubblicitari tipo quel libretto di quel tizio fiorentino. Bisogna fidarsi esclusivamente di persone che presentano il badge del Ministero come me” e mi fece vedere una tesserina argentata che riportava a chiare lettere “Paola Nardi – Dirigente di secondo livello – Ministero della Morte”.
Annuii. Lei attese per qualche secondo che dicessi altro, poi passò alla fase successiva della sua evidentemente molto affollata scaletta mentale: “Allora, se non ha altre domande, questi sono i fogli per acconsentire al viaggio, l’assicurazione in caso di cadute accidentali mentre vola sull’Afghanistan – non che succeda nulla, eh, ora che è morto, ma le ricerche per ritrovare le persone in mezzo a tutte quelle montagne sono sempre un problema e qui può firmare per l’attivazione del Welfare speciale del Ministero.”
Dopo aver firmato, mi invitò a seguirla in un’automobile dai vetri oscurati, ringraziandomi per la collaborazione.
II
Riassunto delle caratteristiche tecniche del veicolo in dotazione alla Dirigente, dott.ssa Nardi, dell’Ufficio 465 ter del Ministero della Morte.
Trattasi di trasportatore di vecchia generazione, dall’aspetto esterno grigio da autovettura in dotazione ai dignitari del Partito Comunista dell’Unione Sovietica e dall’interno spazioso simile a un pulmino Volkswagen, con annessi benefit anni Settanta tipo riserve illimitate di LSD per non percepire l’incoerenza della situazione e musica di Janis Joplin. Possibilità di camuffamento esterno estremamente varia: le opzioni vanno dal manifesto di Togliatti, molto in voga negli anni cinquanta ma attualmente poco utilizzato in quanto potenzialmente sospetto, al velivolo di piccole dimensioni con dietro un lungo striscione “Tanti auguri Mara” utile soprattutto in caso di trasporti estivi in località di mare dove una Mara, a cercarla bene, si trova. Ha la capacità di volare, ma non quella di rendersi completamente invisibile in quanto tale accessorio avrebbe comportato un sovrapprezzo del 25% e il Ministero in quel periodo era in una fase di austerity. Tanto, comunque sia, anche se qualcuno colpisse il veicolo non ci sarebbero particolari effetti per gli occupanti, essendo tutti, salvo errori, già morti. Ci sarebbe solo lo spiacevole inconveniente di doverli andare a cercare in qualche luogo sperduto e tendenzialmente dimenticato dalle mappe. Quindi, come consiglio generale, meglio non dare troppo nell’occhio in scenari di guerra.
III
Il viaggio trascorse sereno, fatta salva qualche comprensibile turbolenza data dall’insistenza della dottoressa Nardi a sorvolare il confine russo-ucraino nonostante le mie riserve a riguardo.
“Il navigatore dice di passare di là.”
“Ma il navigatore lo sa che c’è una guerra in corso?”
“Credo di sì, al Ministero lo aggiornano ogni giorno”
Evidentemente al Ministero non erano però aggiornati sui piani di battaglia dell’esercito russo, perché si rese necessario schivare due o tre missili diretti verso l’Ucraina e un caccia in rotta verso non so dove, con profondo fastidio della dottoressa Nardi, che osservò più volte come la litigiosità umana le fosse profondamente incomprensibile e come non fosse possibile che una persona per fare un lavoro tutto sommato di pubblica utilità e di supporto al prossimo dovesse anche imparare a schivare i cacciabombardieri.
Io, seduto dietro, la osservavo con un certo distacco – almeno, da morto, in attesa di capire com’era il mondo di là, potevo evitare di pensare alle incombenze del mio lavoro di ingegnere in una ditta di sistemi di sicurezza e documentarmi su quello che mi attendeva grazie a due opuscoli “Favoriamo il passaggio” posti sui sedili posteriori. Sulla copertina erano ritratte persone sorridenti di una certa età – segno che io ero ampiamente fuori target per il di cui sopra passaggio, cosa che feci notare alla dottoressa Nardi ottenendo una scrollata di spalle in risposta – mentre all’interno veniva delineata una complessa architettura burocratica che, a quanto pare, mi aveva attentamente selezionato per il viaggio.
“Complimenti! Se stai leggendo questo, vuol dire che il Ministero della Morte ti ha inserito nel Decreto Flussi di questo mese! Con questo viaggio, ti allontanerai dai problemi del neoliberismo, dai tagli alla sanità, dall’allungamento dell’età pensionabile, dalla necessità di lavorare senza mai essere felice per raggiungere un luogo in cui le tue esigenze saranno prese in considerazione”
L’incipit sembrava interessante, anche se notai una certa personalizzazione del messaggio a fini probabilmente imbonitori dato che in alto a destra era specificato “giovane di sinistra arrabbiato”. Mi chiesi come potesse essere l’opuscolo destinato agli anziani di destra, probabilmente era qualcosa del tipo “Hai sempre sognato di vivere in un mondo senza comunisti? Sei davvero fortunato ad essere morto, perché ora puoi farlo serenamente!”
“Mi sembra che siate molto compiacenti negli opuscoli” dissi alla dottoressa Nardi, che nel mentre stava imprecando mentre la contraerea ucraina rispondeva al caccia russo di cui sopra, lei dopo qualche secondo osservò: “Abbiamo un team dedicato al Ministero. Vogliamo che il momento del passaggio – fece una nuova pausa per evitare il caccia che tornava indietro – risponda alle aspettative di ognuno”
“Sì, va bene, ma come potete promettere a tutti quello che vogliono?”
“Oh, le esigenze umane sono semplici. È più facile di quanto credi – di nuovo quel “tu” da corso di comunicazione efficace – comunque basta che aspetti un attimo e avrai modo di vederlo direttamente”
L’automobile si impennò e tutto intorno sembrò oscurarsi.
IV
Dal discorso del Molto Onorevole Gianrico Giustiniani alla giunta del Comitato Centrale del Ministero della Morte, anno 2024
“Secondo me è un problema legato al nome, sapete? Ci chiamiamo Ministero della Morte e la gente pensa che a noi fa piacere se muore e quindi non si fa pregare due volte, muore, muore sempre di più e qui ci riempiamo. Lo ribadisco: la situazione è critica. Lo spazio adibito all’accoglienza si espande di 2 km al giorno e questa velocità, che ha sempre funzionato in modo adeguato, persino ai tempi della peste nera, pensate un po’, ora è insufficiente. Tra un po’ saremo pieni di gente che non sapremo dove mettere, è assolutamente folle! Che cosa possiamo fare? Possiamo permetterci tutto questo? Io dico di no, signori, e vi dico di più: aiutiamoli a casa loro. Basta con questa moda di morire, con questa cosa che basta un nulla per mandare un po’ di persone in guerra, con questa cosa che se ci sono delle problematiche si risolvono buttando un po’ di gente qui da noi. Non-va-bene (scandisce), dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Forse – e dico forse – siamo troppo attrattivi. Quel periodo in cui lasciavamo che il marketing nel mondo di là fosse gestito con la storia dell’inferno forse – e dico forse – non era un’epoca buia come qualcuno – forse e dico forse in malafede – sembra pensare. La retorica laica dell’Aldilà senza Dio e senza diavolo ha aperto i cancelli a tutti questi che si rifugiano da noi. Ma, ripeto, dove li mettiamo? Dico a voi, cari i miei laici: dove-li-mettiamo (scandisce)?”.
V
Ammetto che mi sarei aspettato un’accoglienza più calda. In fondo, ero morto da poco (a causa, avrei scoperto dopo poco compilando la documentazione d’ingresso, di una misconosciuta malattia cardiaca che poi sarebbe stata studiata e avrebbe dato fama e gloria a un certo Professor Katzen, venendo poi denominata Cardiomiopatia di Katzen) ed ero anche un po’ traumatizzato da quanto era successo – intendiamoci, non tantissimo, anche perché non è che la mia vita fosse entusiasmante, quindi la prospettiva di sperimentare qualcosa di diverso in fondo aveva un che di intrigante. Invece, niente: atterrammo in una sorta di piazzola d’asfalto in mezzo a un prato apparentemente sconfinato e il comitato di accoglienza era costituito da una parte da una serie di tizi dai vestiti vagamente bavaresi con lo striscione “Tornatene a casa tua, qui non ti vogliamo” (lo presi come un caldo auspicio di resurrezione, in fondo non credo che avrei gradito un cartello “Grazie per aver infine tirato le cuoia”), dall’altra un tale dal collo taurino e dai piccoli occhiali che come saluto mi fece presente che l’isola su cui vivevano Elvis e John Lennon era coperta da privacy.
“E Kurt Cobain?”
“Pure lui è lì. Privacy.”
Mi spiegò un po’ di regole del luogo, che sembrava vertessero molto sul fatto di non chiedere dove vivesse Elvis, dato che a quanto pareva non vi erano grosse problematiche legate a violazioni della legge, né particolari rischi legati all’attraversare la strada con il semaforo rosso o al fare il bagno troppo presto dopo aver mangiato. Feci presente al signor Kouliakis, doganiere, come recitava il suo cartellino identificativo, che sicuramente dovevano aver rotto molto le scatole al povero Elvis in passato, ma che ormai era tempo che era passato di moda. Il signor Kouliakis mi guardò perplesso.
“Senta, purtroppo siamo in un periodo di ristrettezze… Li vede quelli là, no? – accennò ai bavaresi dall’altra parte della piazzola – Arrivano troppe persone e non sappiamo dove metterle. Lei chiaramente non c’entra nulla, ma visto che è una persona ragionevole Le chiederei di darci una mano. Si tratterebbe di vivere – cioè, di morire – per un po’ nei locali del trentunesimo piano del Ministero della Morte. Sono locali molto moderni, hanno tutto il necessario per godersi la morte – un letto per fare quei viaggi dimensionali che nel mondo di là chiamano sogni, un po’ di libri, il bagno, glielo dico prima che lo chieda, non serve e se ne renderà conto presto. Le saremmo grati se ci aiutasse.”
Non menzionò il fatto che il trentunesimo piano del Ministero della Morte era stato soprannominato “l’alveare” per via della densità abitativa, né che, a causa di varie concomitanze nei decessi, vi risiedeva una cellula trozkista molto attiva composta di russi barbuti che andavano a bussare a tutte le porte per parlare male di Stalin. Tendenzialmente, era meglio ascoltarli, perché si irritavano facilmente e del resto erano probabilmente morti tutti in modi orribili a causa di Iosif Vissarionovic, quindi forse qualche ragione l’avevano anche. Ma non anticipiamo troppo. Dopo aver garantito la mia totale collaborazione e aver salutato il doganiere, fui fatto salire su una Fiat Panda verde apparentemente molto vetusta (la dottoressa Nardi fece presente che il Ministero aveva attraversato un periodo di difficoltà intorno al 2017 e che questi erano i risultati) e insieme alla dirigente del Ministero ci lanciammo a 150 km orari verso la fine del prato.
Impiegammo circa tre ore per arrivare in fondo al prato (“Sai, è un prato di rappresentanza, ci fa piacere che chi arriva abbia l’impressione di un luogo tranquillo e immerso nel verde”) e, superato un piccolo bosco, entrammo in un passaggio suburbano fatto di piccole villette rosa (“Sono gli interventi degli anni Sessanta, carini vero?”), attraversammo una sorta di grande villaggio medioevale con tanto di contadini baffuti in abiti tipici (“Sono qui dalla peste del 1348 e non si sono mai integrati, a volte purtroppo capita”) e infine, superato un ponte estremamente lungo ed estremamente stretto, ci fermammo su una piccola isola in mezzo a un grande fiume su cui era presente soltanto un grattacielo. La dottoressa Nardi mi fece presente che eravamo infine giunti al Ministero della Morte.